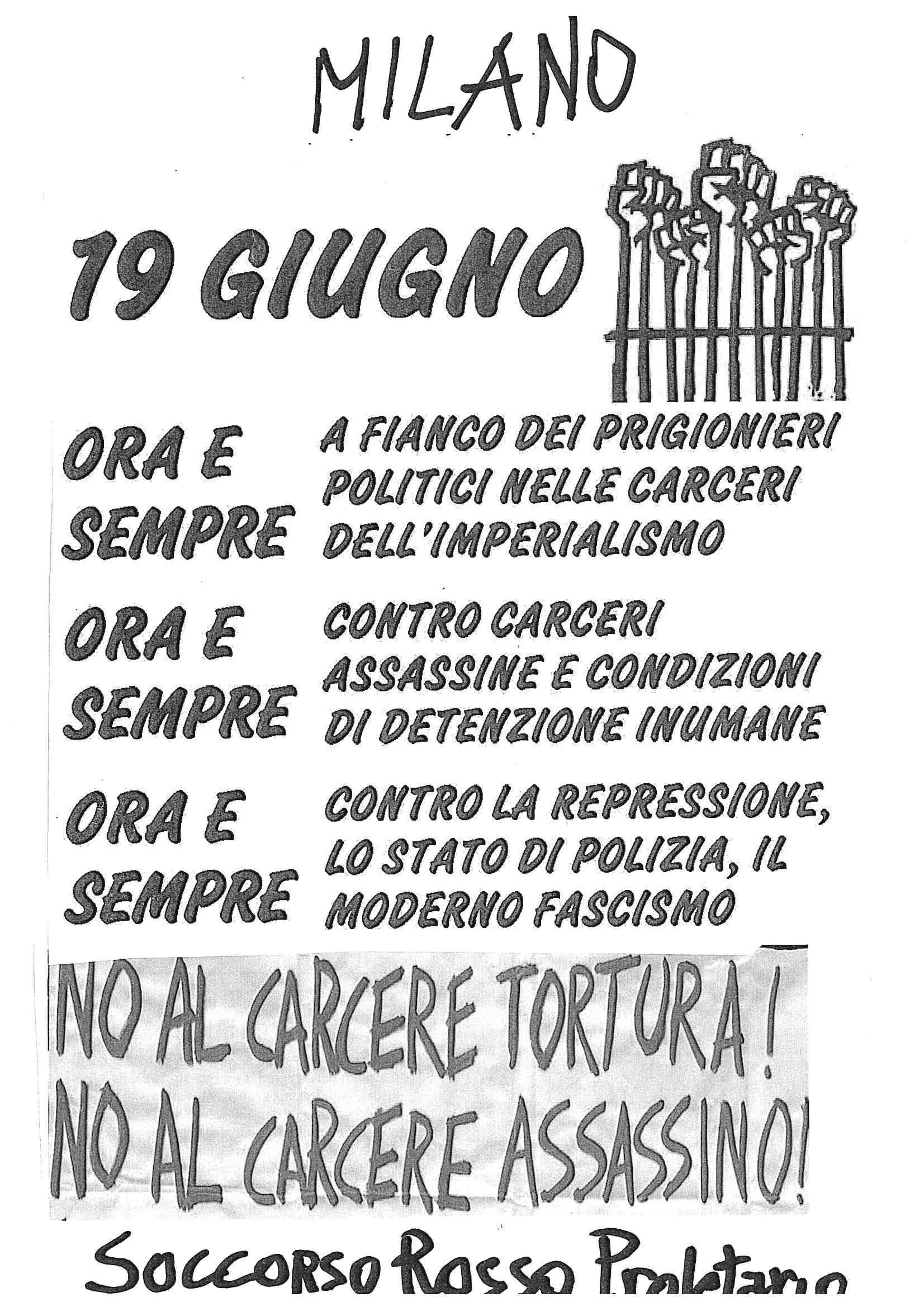NDR e ABS. Alla voce “anamnesi personale”, nella copia sbiadiata del diario clinico di Salvatore “Sasà” Piscitelli, sono annotate due sigle. Una sta per “niente da rilevare”. L’altra significa “apparente buona salute”, come spiegano i medici che in carcere lavorano. L’aggettivo BUONO si intravede anche nella casella “esame obiettivo”. Molti altri riquadri sono in bianco, vuoti.
Le 21 pagine della prima ricostruzione ufficiale
Un anno dopo le rivolte – e la morte di Sasà e altri dodici detenuti – vengono alla luce gli atti contenuti nel sottofascicolo aperto dalla procura di Modena, i risultati degli accertamenti effettuati dalla pm Lucia De Santis prima di spogliarsi della competenza e di ripassare l’inchiesta alla procura di Ascoli, da dove le era arrivata. Sono solo 21 pagine, le prime di fonte giudiziaria. Ma forniscono informazioni inedite, offrono spunti, alimentano dubbi. Sulla ultime ore di Sasà raccontano una storia diversa da quella ricostruita e denunciata da almeno sette compagni di viaggio e di detenzione. Sembra un altro uomo, un quarantenne sano e in forze, senza problematiche particolari, senza bisogni urgenti. E’ morto, qualche ora dopo l’incontro con un medico, la compilazione (parziale) del diario clinico, le sigle e gli aggettivi tranquillizzanti.
«Decesso presso il carcere di Ascoli»: lapsus della pm?
Il 23 marzo 2020, due settimane dopo la morte di Sasà Piscitelli, la pm modenese scrive alla direzione del carcere di Ascoli Piceno, dove nella notte tra l’8 e il 9 marzo il quarantenne era stato portato assieme a 41 compagni. Chiede di riferire le condizioni del detenuto all’arrivo in istituto, le circostanze del decesso, le attività di verifica dell’eventuale possesso di psicofarmaci, medicinali o stupefacenti, la documentazione medica sullo stato di salute nel tempo passato nella struttura. Nell’intestazione della richiesta la pm colloca la morte «presso la casa circondariale di Ascoli Piceno». Non sa che Sasà è deceduto in ospedale, come sostengono nella città marchigiana? O il suo è un banale errore di compilazione oppure un laspus?
Le cose che la direttrice non può sapere
La direttrice, Eleonora Consoli, si prende qualche settimana per raccogliere e comunicare le informazioni richieste. Risponde alla pm il 14 maggio. Precisa che il detenuto Salvatore Piscitelli è morto alle 17.25 presso l’ospedale civile di Ascoli Piceno, non in carcere. Riferisce che era arrivato in istituto alle 00.25 del 9 marzo 2020 assieme ad altri 41 ristretti, «tutti provenienti dalla casa circondariale di Modena, in quanto avevano partecipato ai disordini/rivolta avvenuti all’interno dell’istituto di Modena l’8.3.2020». Non chiarisce come facesse lei a sapere che i nuovi giunti fossero stati coinvolti nelle azioni di protesta e di devastazione, se non richiamando genericamente il provvedimento con cui il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ha disposto i trasferimenti e d’urgenza. Lo dà per scontato. Però nel verbale da lei allegato alla relazione, l’ultima pagina del suo rapporto, il compagno di cella di Sasà sostiene una cosa diversa. Il quarantenne, garantisce Mattia, non aveva aderito alla rivolta.
Il compagno: «Sasà non ha preso parte alla rivolta»
Mattia Palloni è uno dei cinque ragazzi che a novembre sottoscriveranno un esposto – choc, per denunciare pestaggi, abusi, torture. Sulla morte di Piscitelli viene sentito la prima volta, con la formula delle dichiarazioni spontanee, non a ridosso del decesso del compagno, ma a quasi due mesi di distanza. Il 2 maggio, messo di fronte a due assistenti e a un sovrintendente della polizia penitenziaria, non è molto loquace. Pare intimidito. Sostiene che lui e Sasà non presero parte alla sommossa di Modena. All’inizio avevano deciso di rimanere nella loro cella, condivisa. Poi furono costretti a uscire, perché la sezione era stata invasa dal fumo, provocato dall’incendio di suppellettili e arredi. Rassicurato il personale sanitario e un agente rimasti chiusi dentro un ambulatorio, sempre stando alle dichiarazioni spontanee di allora, entrambi raggiunsero il piazzale e altri reclusi. Qui un altro carcerato, sconosciuto, passò a Sasà una bottiglia di metadone (prelevato dall’armadio blindato dell’infermeria, aperto con la chiave e non forzato, o forse presa dal tavolo usato da due infermiere per preparare le dosi da distribuire). Mattia cercò di non farlo bere. Non ci riuscì. E il compagno, inghiottita il liquido, restituì la bottiglia al fornitore.
Un medico solo per visitare 42 detenuti?
La direttrice, tornando all’arrivo al carcere di Ascoli, conferma l’avvenuta perquisizione e l’immatricolazione di Sasà. Scrive alla pm che alle 2.30 viene sottoposto alla visita di primo ingresso dal medico di turno del Servizio integrativo assistenza sanitaria, Simone C. In quella notte non ordinaria è presente un solo dottore, lui, posto di fronte a una impresa titanica: sottoporre ad accertamenti sanitari di base 42 detenuti e non detenuti qualunque, bensì i ragazzi e gli uomini in arrivo da un carcere devastato da una sommossa, dopo una razzia di litri di metadone e di una gran quantità di psicofarmaci. «A molti di noi – renderanno poi noyo gli autori dell’esposto di novembre – non fu neanche chiesto di togliersi gli indumenti per constatare se avessimo lesioni corporee». Per verificare le condizioni di Sasà, con trascorsi di tossicodipendenza e un fisico provato, il medico ci mette 15 minuti: dalle 2.30 alle 2.45, almeno stando all’appunto sul diario clinico. Alle 3.00 il detenuto in “apparente buona salute” viene collocato nella cella 52 del secondo piano, lato sinistro, reparto marino.
Per 10 ore nessuna notizia del detenuto in agonia
Per più di 10 ore su Sasà non ci sono annotazioni della direttrice. E’ come se sparisse, da notte fonda al primo pomeriggio. La colazione non gli è stata portata? E le sue medicine, le benodiazepine richiamate nel diario clinico alla voce “terapia in corso”? Gli agenti del turno 8/14 e il personale sanitario non hanno mai guardato dentro la cella 52? La relazione della direttrice riprende il filo, dopo questo vuoto totale, alle 13.20. A quell’ora, scrive alla pm, «il ristretto non risponde agli stimoli del personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza». Viene chiamato il medico di guardia Sias, Cristiano M.D.V, in servizio dalla prima mattinata.
La chiamata al 118 e l’arrivo dell’ambulanza
Il dottore capisce che la situazione è gravissima, sollecita l’intervento del 118 e gli inietta una fiala di Narcan (indicato poi con Naloxone) per “sospetta overdose di metadone”. Arriva l’equipe esterna, con il dottor Ihaab A. L’ambulanza con a bordo Sasà, diretta d’urgenza all’ospedale civile di Ascoli, lascia il carcere alle 15.15. Una seconda lettiga carica un altro recluso “modenese” che ha bisogno di assistenza specializzata. Alle 17.25 il dottor Guido G. constatata e certifica la morte del detenuto Piscitelli, giunto e trattenuto al pronto soccorso in «stato di coma avanzato da verosimile intossicazione da farmaci».
La testimonianza del medico del carcere
«Mi sono attivato subito – dice adesso il dottor M.D.V, al telefono – appena gli agenti mi hanno chiamato in sezione. No, Piscitelli non avevo avuto modo di vederlo prima. Erano arrivati in più di 40, da Modena. Quando sono entrato in cella – riferisce – sembrava che dormisse. Ho provato a svegliarlo, ma non ha riaperto gli occhi. L’overdose di metadone non è così semplice da diagnosticare e su di lui non avevo informazioni. Gli ho fatto una iniezione di Narcan, poi l’ho affidato al personale del 118. Non è morto in carcere. Il detenuto – ripete – è uscito dall’istituto ancora vivo. So che è deceduto in ospedale, dopo. Sono stato convocato dal magistrato, come testimone. Ho raccontato tutto questo, documentato. Non c’è un’altra verità».
Mai scritti – e non distrutti – i nulla osta ai trasferimenti
La direttrice Consoli mette nero su bianco un’altra informazione. Piscitelli e i 41 compagni sono stati trasferiti d’urgenza nel suo istituto, «senza essere accompagnati da nessun fascicolo e/o altro documento». Perché? Lei, ecco il punto, non può avere contezza diretta del motivo. Però, senza dichiarare la fonte, scrive che «è andato tutto distrutto» nella rivolta. E’ vero per le carte redatte a Modena prima della sommossa. Non vale per gli atti successivi. All’arrivo ad Ascoli mancano altri documenti, quelli che per legge i medici avrebbero dovuto compilare dopo le violente azioni di protesta e prima delle traduzioni: i certificati delle visite effettuate a Modena e i nulla osta sanitari con l’ok al viaggio dall’Emilia alle Marche. Questi attestazioni non sono mai state scritte. I medici tenuti a redarle si sono giustificati dicendo che è mancato loro il tempo di provvedere, vista la situazione drammatica e l’alto numero di persone da assistere.
Ordine e sicurezza prima della salute
Non si fa riferimento ai nulla osta sanitari mancati nemmeno nel provvedimento con cui il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ha disposto lo sfollamento dei 42 detenuti “modenesi” destinati ad Ascoli. A firmare l’ordine di trasferimento – il pomeriggio o la sera dell’8 marzo, in un orario non indicato – è Silvia Della Branca. Il carcere emiliano è in gran parte distrutto, inagibile. Decine e decine di reclusi devono avere una sistemazione alternativa e in fretta, visto che sta facendo notte. La funzionaria motiva la disposizione con esigenze di ordine e sicurezza. Il poliziotto penitenziario a capo della scorta, quello che dovrebbe avere con sé i nulla osta sanitari al viaggio, per iscritto viene invitato a sorvegliare in modo adeguato i detenuti per impedire tentativi di evasione, anche con appoggi esterni, e «altri inconvenienti di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare svolgimento della traduzione». Dalla casa di reclusione di Modena sono usciti parecchi detenuti in overdose e a tarda sera si sono contati tre morti, i primi di nove. Però in queste disposizioni non c’è alcun riferimento alle possibili condizioni di salute dei trasportati, né all’opportunità di avere medici al seguito e neppure alla necessità di dotarsi almeno di farmaci antagonisti salvavita.
Come stava davvero Sasà?
Sasà durante il viaggio cade in uno «stato di torpore», come dirà il 2 maggio il compagno di cella, Mattia. Il dottor Simone C., il medico che lo visita nel carcere di Ascoli o che attesta di averlo visitato, non lo rileva o non lo annota. Nel diario clinico sono più le parti in bianco di quelle compilate. NDR, ABS e BUONO certificano condizioni di salute non preoccupanti. Le carte non spiegano se sia o no al corrente del furto di metadone e di psicofarmaci e delle overdosi in serie, nel carcere di provenienza. Quello che si vede è che non ha riempito lo spazio per registrare eventuali “lesioni all’ingresso” né le caselle riservate a “sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti” e “sindrome di astinenza in atto”. Le ha barrate con una riga, senza compilare altri campi né registrare parametri di base (ad esempio pressione, frequenza cardiaca, temperatura, auscultazione dei polmoni). In compenso, dopo la visita lampo, per Sasà ha valutato come “alto” il rischio di suicidio.
Versioni opposte sulle ultime ore di vita
Il vuoto dalle 3.00 alle 13.20 nella relazione inviata dalla direttrice alla pm di Modena verrà colmato dalle lettere denuncia spedite in estate da due detenuti e dall’esposto di fine novembre 2020 firmato da Mattia Palloni e altri quattro compagni, ascoltati dalla procura emiliana a dicembre. «Sasà – concordano, con accuse tutte da dimostrare, diventate oggetto di indagine – è stato picchiato prima, durante e dopo il viaggio. Stava malissimo ed era debole, non riusciva a reggersi in piedi. Ad Ascoli è stato trascinato fino alla sua cella e buttato dentro come un sacco di patate. La mattina del 9 marzo il compagno di stanza ha chiesto inutilmente aiuto e più volte. Nessuno è accorso ad aiutare Sasà. Si è sentito un agente pronunciare: “fatelo morire”». Sempre secondo i reclusi – testimoni, che non hanno competenze mediche e che non disponevano di strumenti diagnostici, il quarantenne sarebbe «morto in cella, portato via con un lenzuolo quando era già freddo». I medici con cui Piscitelli è stato a contatto, come detto, raccontano e certificano altro: il decesso in ospedale.
L’inchiesta è tornata nelle Marche
L’inchiesta è tornata nelle Marche, con i magistrati chiamati ad esaminare anche un esposto firmato dall’associazione Antigone, già presente nell’inchiesta modenese come persona offesa. Dagli uffici giudiziari interessati – procura di Ascoli e procura generale di Ancona – non escono notizie né aggiornamenti. La sola indicazione fatta filtrare un paio di settimane fa, veicolata da un criptico servizio del tg Rai regionale, allude a una autopsia bis (sulle carte e sui campioni e gli organi prelevati, poiché la salma di Sasà è stata fatta cremare “causa Covid”) oppure alla rilettura degli accertamenti post mortem alla luce delle omissioni, dei pestaggi e degli abusi denunciati dai compagni di viaggio e di cella. (lorenza pleuteri – per la foto si ringrazia la cooperativa teatrale Estia)



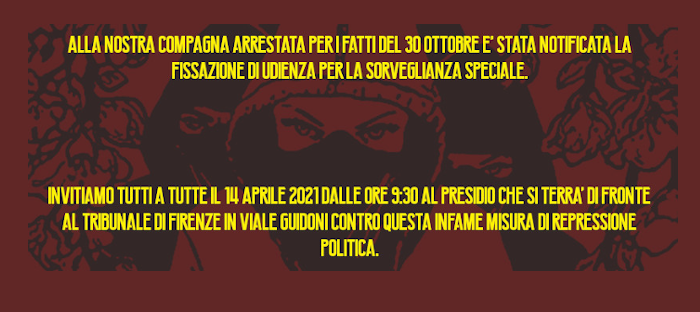 UN DESERTO SOCIALE A TUTTI I COSTI
UN DESERTO SOCIALE A TUTTI I COSTI